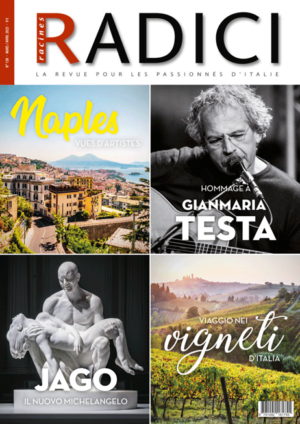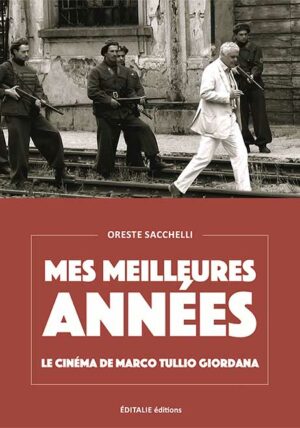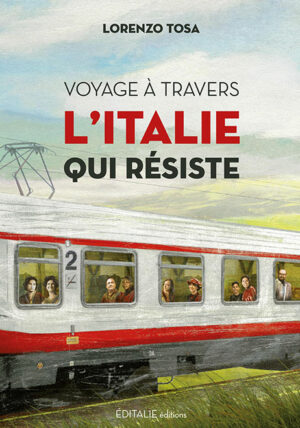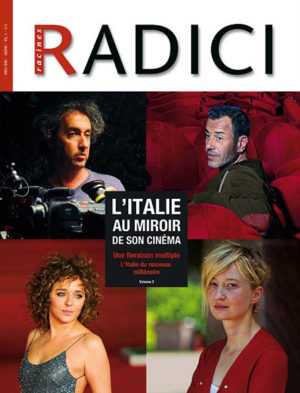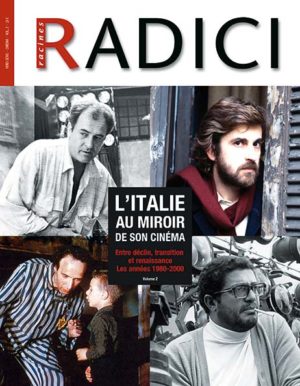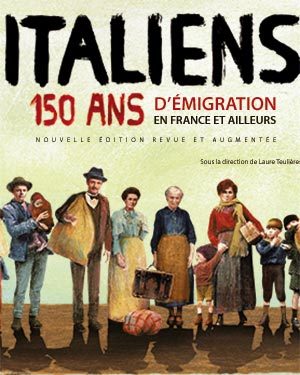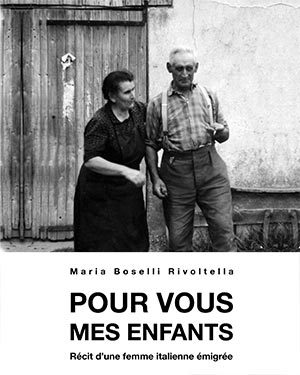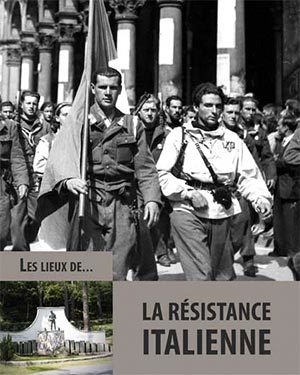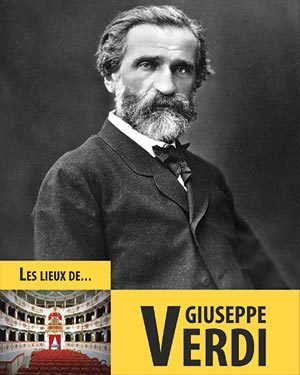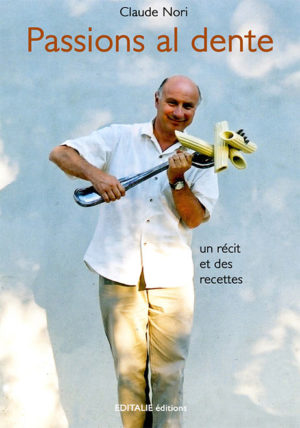“Fuori mano”, sperduto ai confini del mondo: è così che, da Palermo, il Principe di Salina, personaggio del romanzo Il Gattopardo colloca il Piemonte. Eppure, per chi entra in Italia in treno dalla Francia, il Piemonte è la prima regione attraversata. Con la riapertura, questa primavera, della linea ferroviaria Parigi-Lione-Chambéry-Torino, RADICI propone per questo itinerario d’estate un viaggio a passo lento – ogni luogo è stato raggiunto in treno o in autobus – alla scoperta di alcun luoghi bellissimi del Piemonte, meno conosciuti di Torino o delle Langhe. Ma anche di luoghi-simbolo di minoranze religiose storicamente insediate in questa regione. Il tutto lontano dagli schermi dei codici digitali degli affitti brevi e dal ronzio delle valigie a rotelle sui sanpietrini.
CÉCILE GOTTRY
FENESTRELLE, LA GRANDE MURAGLIA DELLE ALPI
In cima a una montagna… le parole della canzone Sant’allegria di Ornella Vanoni ci risuonano nella mente, mentre sopra le nostre teste aquile e poiane volteggiano in un paesaggio mozzafiato. Di fronte a noi, i 3000 metri del Monte Albergian, ogni anno meno innevati. Siamo a 1800 metri, al Forte delle Valli, punto culminante e, dal 1728, punto di partenza per la costruzione di Fenestrelle, che durerà 122 anni. Il più grande complesso fortificato d’Europa corre lungo la cresta di un rilievo del Monte Pelvo.
La visita comincia al Forte San Carlo, a quota 1230 metri, e prosegue affrontando circa 2500 gradini (l’equivalente di 167 piani) della Scala reale, all’aperto, e, in alternativa, quelli coperti della Scala coperta, che le corre accanto.
Nel 1883, lo scrittore e giornalista Edmondo De Amicis descrive la sua emozione davanti a queste due scalinate emblematiche di Fenestrelle: “[…] una sorta di gradinata titanica che dalla cima di un monte alto quasi duemila metri vien giù fin nella valle. […] Una cosa strana, grande, bella davvero.”
Ascoltando la guida Michele raccontarci aneddoti e storia di questa fortezza voluta da un re di Sardegna per difendere il Piemonte dagli assalti francesi, non possiamo che essere grati agli appassionati dell’associazione Progetto San Carlo, che hanno salvato Fenestrelle dalla vegetazione divorante e dal degrado in cui era sprofondata.
Fenestrelle non fu mai teatro di battaglia: come i soldati del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, anche qui si attese un nemico che non arrivò mai. Nel 1747, infatti, i francesi, scoraggiati dall’inespugnabile fortezza, preferirono attaccare a 2500 metri di quota!
Ma Fenestrelle fu anche prigione, persino per ospiti illustri, come il segretario di papa Pio VII, imprigionato qui per ordine di Napoleone.
Impossibile rimpiangere anche un solo minuto l’ora di autobus da Pinerolo!
PINEROLO, I CAVALIERI E IL MISTERO DELLA MASCHERA DI FERRO
Scendendo nella pianura, la prima città che incontriamo è Pinerolo – Pignerol, se vogliamo, dato che questa città ha detenuto il record della più lunga permanenza sotto bandiera francese: ben 120 anni in totale. Un tempo, da Fenestrelle ci si arrivava a cavallo.
Simbolo per eccellenza di Pinerolo, proprio il cavallo fu il cuore pulsante della Scuola di Cavalleria del Regno, attiva qui fino al 1943. Oggi, i suoi locali ospitano il Museo Nazionale dell’Arma di Cavalleria.
Si racconta che ci fossero fino a 750 cavalli per 12.000 abitanti – stando a quanto riferito dalla guida del museo, che si basa sul fatto che ogni allievo disponeva di diverse cavalcature per l’addestramento.
Uno di quegli allievi, il geniale Federico Caprilli, rivoluzionò nel 1902 la tecnica del salto a ostacoli: fino ad allora, il cavaliere restava seduto sulla sella e tirava indietro la testa del cavallo!
Un’altra singolarità di Pinerolo? Qui Luigi XIV fece marcire in prigione per lunghi anni il celebre Uomo dalla Maschera di Ferro, la cui identità rimane ancora oggi un mistero. Negli anni pari, un fine settimana di ottobre, la compagnia teatrale La Maschera di Ferro rievoca questa vicenda storica con centinaia di figuranti, come ci racconta Luigi Oddoero, la cui moglie ha cucito ben 300 costumi. Chapeau!
È una domenica pomeriggio e la cittadina, avvolta attorno al suo duomo di San Donato, sonnecchia al sole. Verso la stazione, lo sguardo viene catturato da una targa che recita: “Quando a morire per il lavoro eravamo noi”, in memoria di un cittadino di Pinerolo caduto nella strage degli operai italiani ad Aigues-Mortes, in Francia, nel 1893.
LA VAL PELLICE E I VALDESI, I “CATARI” D’ITALIA
Restiamo nel sud-ovest del Piemonte ed entriamo nella Val Pellice, che insieme alla Val Germanasca e alla Val Chisone costituisce il cuore storico delle valli valdesi.
Cosa sono le valli valdesi? Le terre d’origine dei membri della Chiesa valdese, nata nel XII secolo a Lione grazie a un mercante, Valdo, che predicava il ritorno alla povertà evangelica come unico riferimento. Oggi, è la principale confessione protestante in Italia.
Eppure, la storia di questi difensori della sola fede eterodossa di origine medievale giunta fino a noi, come ci ricorda Davide Rosso, direttore del Centro Culturale Valdese, è segnata da persecuzioni e tentativi di annientamento. Nel XVII secolo, una repressione durissima voluta dal re d’Italia e dal principe del Piemonte li costringe a rifugiarsi in Svizzera.
Al ritorno, i valdesi, spesso contadini, dovranno abitare solo oltre i 600 metri di altitudine. Solo nel 1848, grazie alle leggi liberali, potranno finalmente scendere a valle e mettere radici a Torre Pellice.
E fu proprio così: nella cosiddetta “Ginevra d’Italia”, sorsero edifici ordinati e ben tenuti, che formano un quartiere coeso e armonioso, incorniciato da montagne verdi.
Fra i personaggi che hanno lasciato il segno, spicca Lidia Poët, valdese e prima donna iscritta all’albo degli avvocati in Italia nel 1883, benché allora le fosse proibito esercitare.
SALUZZO, L’EREDITÀ DI UN MARCHESATO PROSPERO
Proseguiamo verso sud, alla volta di Saluzzo, ai piedi del possente Monviso, la montagna che nutre la memoria della famiglia Ughetto nel film d’animazione Interdit aux chiens et aux Italiens (Alain Ughetto, 2023 – titolo italiano: Manodopera), ispirato alla storia familiare del regista.
Saluzzo è forse il segreto meglio custodito del Piemonte. Il fascino del centro storico in alto è immediato e avvolgente: terrazze di ristorantini servono i classici agnolotti del plin, ravioli della tradizione locale, mentre alcuni bar animano le vie con una certa sobrietà. Verde, fiori, e scorci poetici si susseguono in salite, scalette e piazzette dedicate a nomi santi: Bernardo, Chiara, Martino, e Giovanni, cui è dedicata una splendida chiesa. L’abside in gotico fiammeggiante, con la sua pietra cesellata come un merletto, conquista più del monumento funebre al marchese Ludovico II di Saluzzo, realizzato da un artista rinascimentale passato per la Certosa di Pavia. Scusate se è poco. Una testimonianza dell’antica potenza dei marchesi di Saluzzo, che dal XII al XVI secolo seppero essere mecenati raffinati e signori di una sfolgorante corte.
Saluzzo ha anche dato i natali a figure illustri, come, nel XIX secolo, lo scrittore romantico e carbonaro Silvio Pellico, autore di Le mie prigioni, racconto celebre ispirato agli anni trascorsi in una sinistra fortezza della Moravia.
Passeggiando, un cartello attira la nostra attenzione: Via dei deportati ebrei. Poco più in là, un’altro indica la sinagoga, che ci conduce in un cortile silenzioso. Al piano alto, dietro le persiane chiuse, si intravede una balconata: è lì che si trova la sinagoga di Saluzzo.
PIEMONTE, UNA STORIA EBRAICA
Quei cartelli che indicano “sinagoga” o “ex quartiere ebraico”, li ritroveremo in molte città del Piemonte: Cuneo, Vercelli, Casale Monferrato, Asti, Alessandria, Ivrea, solo per citarne alcune. E viene naturale ricordare che tre figure fondamentali del Novecento italiano erano piemontesi ed ebree: Primo Levi, voce imprescindibile della memoria, Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina, e Carlo Levi, autore de Cristo si è fermato a Eboli.
Ascoltare il racconto di Baruch Lampronti, giovane architetto impegnato nella valorizzazione del patrimonio ebraico piemontese, è un invito a guardare questa terra con occhi nuovi. Qui, già dal XV secolo si installarono le prime comunità. Ma nel XVIII secolo il re di Sardegna decretò l’obbligo per gli ebrei di risiedere nei ghetti. Da allora, l’ebraismo piemontese divenne urbano, confinato tra mura e portoni. Il Piemonte arrivò a contare ben 19 comunità ebraiche: altrettanti cimiteri, quartieri segregati, sinagoghe.
Oggi molte di queste sinagoghe non sono più utilizzate regolarmente per il culto, ci spiega Baruch, perché le rispettive comunità si sono progressivamente estinte dalla fine del XIX secolo.
La curiosità ci spinge allora a cercare le sinagoghe più antiche, anteriori all’Emancipazione del 1848, riconoscibili per lo stile barocco. E infatti, a Carmagnola, salendo una semplice scala a chiocciola in una casa dimessa, si arriva a una stanza sorprendente: un ampio salone quadrato, raccolto e silenzioso, decorato da boiserie dipinte e dorate, con colonne tortili e intagli minuziosi. La comunità ebraica locale insiste affinché questi luoghi restino accessibili a tutti: basta mettersi in contatto con un po’ di anticipo. Chissà, forse una nuova idea di visita all’orizzonte.
ASTI, SPUMANTE, MA NON SOLO
Scoprire Asti, a sud-est di Torino, significa vivere due anime opposte. C’è l’euforia del Settembre astigiano, con una sequenza di feste che culmina nel Palio di Asti, il più antico d’Italia. Cos’è un Palio? Una corsa a cavallo, vecchia di 750 anni, dove i fantini montano a pelo difendendo i colori del loro rione in Piazza Alfieri. Questa settimana di follia popolare include anche il mercato medievale, le cene all’aperto tra strade addobbate, e soprattutto il Corteo dei bambini in abiti d’epoca – forse il momento più tenero, pensato per trasmettere ai più giovani la passione per la rievocazione storica, tanto amata dagli italiani.
Ma appena passate le feste, Asti ritorna silenziosa, quasi assopita, una bella addormentata, come la chiama Alessia, una studentessa che abbiamo incontrato. E come darle torto? La sera, poche le vie animate. Eppure il fascino resiste, fatto di piazze armoniose, alte torri medievali, tegole romane, motivi in mattoni ben in vista sugli intonaci colori pastello, e palazzi con strutture in ferro battuto o, a giugno, il profumo dei tigli che inebria tutta la città.
Ma è impossibile parlare dell’Italia senza parlare delle sue chiese! La cattedrale di Asti, un imponente edificio gotico in mattoni, accoglie il visitatore in un interno sorprendente: tutte le pareti, le volte, i pilastri sono ricoperti da pitture barocche, spesso in trompe-l’œil, che moltiplicano lo spazio e la luce.
Alla periferia della città, un’ultima meraviglia: in una ex certosa oggi convivono un allegro e colorato asilo insieme ad una storica manifattura di arazzi, la Scassa, riconosciuta come Impresa del Patrimonio Vivente. È l’unica in Italia a praticare la tecnica ad alto liccio, con telai verticali, e il lavoro è esclusivamente manuale. Serve una media di 500 ore di lavoro per un solo metro quadrato di tessuto. Lavorando alla riproduzione di un dipinto di Paul Klee, Franca Alcaro ci racconta che Ugo Scassa, fondatore dell’Arazzeria Scassa nel 1957, fece la scelta dell’arte contemporanea perché “In Italia, l’antico è solo imitazione”. Dixit. Una direttrice della Manifattura dei Gobelins è stata ospite in questa struttura dove, oggi, vengono accolti molti studenti dall’Accademia di Brera di Milano.
Eccoci giunti alla fine di questo viaggio in Piemonte. Alessandria, Biella, Cuneo, Domodossola – in un perfetto ordine alfabetico! – Novara, Vercelli: anche queste città meritano una visita, ma occorre fare delle scelte. La chiusura di più di una linea ferroviaria regionale obbliga talvolta a percorsi “a triangolo”, costringendo a ripassare da Torino. Ostacoli presto dimenticati, soprattutto quel giorno in cui la carrozza del nostro treno si è riempita della celebre canzone degli anni ’70 Amici miei. A intonarla erano delle coriste di un gruppo amatoriale di Parigi, appassionate di canto popolare italiano, che, di ritorno da un concerto qui in Piemonte, ripartivano verso la Francia incantate e cantando.
C.G.
ABBAZIA DI VEZZOLANO, UNA SORPRESA DIVINA
Nel cuore del Monferrato, terra natale di Don Bosco e di dolci colline dove foreste, siepi e colture diverse dalla vite trovano ancora spazio, si scopre una piccola abbazia del XII secolo che suscita un triplo fascino. Il sito, anzitutto: incastonato in una valletta, in fondo a una stradina, sorvegliato da un cipresso imponente e circondato da meli. Il pontile romanico, poi: il muro che separa il coro dei canonici dalla navata dei fedeli, probabilmente l’unico sopravvissuto in Italia dopo le riforme del Concilio di Trento. Le sue sculture, colorate ed espressive, sono vere lezioni di iconografia: ogni personaggio porta una cintura con il proprio nome. La presenza del blu, del lapislazzuli proveniente dal Caucaso, testimonia la ricchezza dei donatori. Infine, il chiostro, con le sue volte a crociera alternate di rosso mattone e bianco pietra, dove si ammira un’Adorazione dei Magi dei XIII e XIV secoli. Peccato solo che a Vezzolano si possa arrivare solo con mezzi propri. Fabrizio Falletto, presidente dell’associazione In collina, sogna un gemellaggio con Serrabone, gioiello romanico dei Pirenei orientali.
I FIGLI DI ASTI
Passeggiando nel centro, davanti alle scuole di via Carducci, ci si ricorda che qui studiò contabilità un certo Mario Bergoglio. Diplomato, partì per l’Argentina alla fine degli anni 1920. Da lì, insieme a una giovane ligure, fondò una famiglia. Tra i figli, Jorge Mario, nato nel 1936: che diventerà più tardi papa Francesco.
E viene in mente quella frase di Paolo Conte – anche lui nato ad Asti, poche settimane dopo l’argentino più amato dopo Maradona – che diceva: “Gli italiani non viaggiano, emigrano”. Paolo Conte, prima di diventare cantautore, esercitò la professione di giurista nello studio del padre. Ancora oggi vive nei dintorni. E lo si capisce. Perché sì… It’s wonderful!