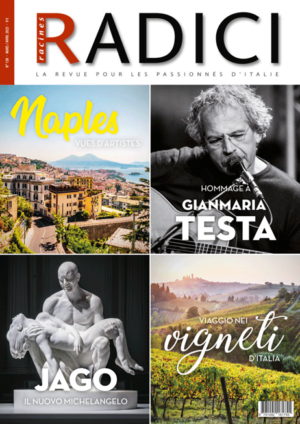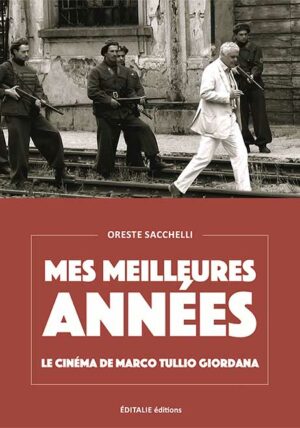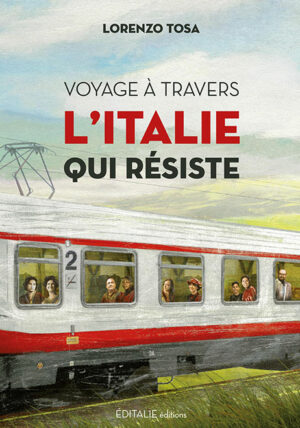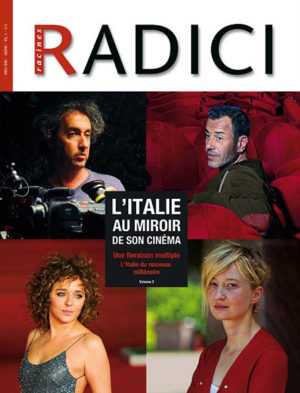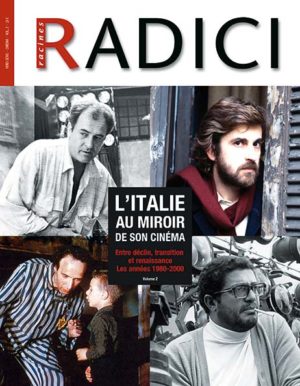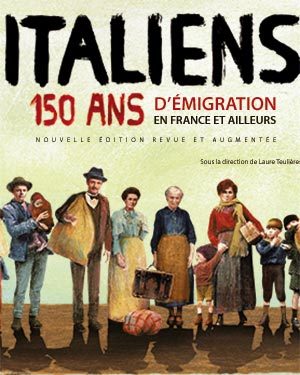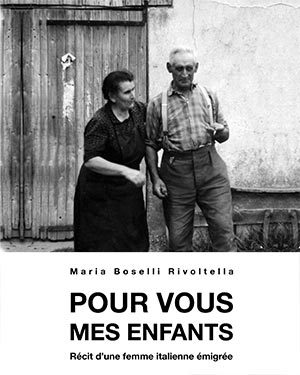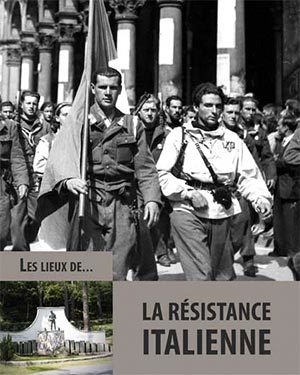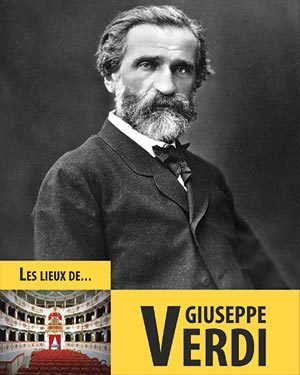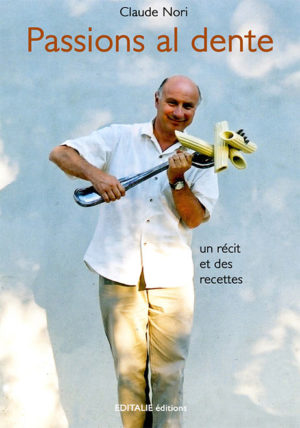Una terra plurale, contesa, poetica, irreparabilmente europea.
MARCO COSLOVICH
L’Istria? La prima volta che l’ho vista è stato da un traghetto lento, in arrivo tra i moli di Pola e l’ombra di un’arena che sembrava aspettare ancora i suoi gladiatori. Era autunno. Un tempo sospeso, quieto. Pochi turisti, nessun rumore. Solo un’aria densa, come se il paesaggio respirasse memorie troppo antiche per farsi parole.
Un tempo e un luogo in cui il passato sembra trattenersi, più che farsi raccontare: nomi cancellati, lingue dimenticate, partenze senza ritorno. Qui, anche le pause della storia sembrano parlare con accento proprio. Come se persino il silenzio avesse imparato a convivere con più lingue.
L’Istria più che accoglierti, ti osserva. Ti misura. Come una vecchia signora che ha visto troppo per lasciarsi intenerire da eventuali complimenti, pur giusti e sinceri. Anche Pola, città portuale affascinante, non si concede a cuor leggero.
Se ci sono terre che si offrono al racconto, l’Istria si sottrae. Perché qui tutto è stato più di una volta: le città, le lapidi, le chiese, le parole. E nulla è rimasto intatto.
Qualcuno potrebbe chiedersi: “ma perché l’Istria in un numero di RADICI?”, una rivista che ha fatto dell’Italia il suo oggetto di riferimento. Altri, più ingenuamente, si chiedono ancora se “sia italiana o slava” – se appartenga più al mondo culturale latino o a quello slavo.
Perché l’Istria è stata per secoli un crocevia conteso, un mosaico di popoli, un luogo dove l’identità non è mai stata univoca. Italiana, slava, austroungarica, jugoslava e oggi croata, questa penisola dell’Adriatico orientale è lo specchio vivo delle fratture del Novecento. E della difficoltà di ricordare senza schierarsi. Oggi, la maggior parte del suo territorio è in Croazia. Una porzione più piccola, lungo la costa settentrionale, è in Slovenia. E solo una piccola parte, Muggia e San Dorligo, è ancora in Italia. È il ritratto vivo di un’Europa dai confini mobili, dove la storia si è intrecciata troppe volte per lasciarsi imprigionare in una sola bandiera.
E allora scopriamola.
Le cicatrici sotto la cartolina
Da fuori, l’Istria abbaglia: mare pulito, borghi perfetti, vini e tartufi, piazzette di pietra chiara che sembrano disegnate per Instagram. Ma sotto quella bellezza c’è una storia scomoda, che non passa mai davvero. Una storia che taglia in due le famiglie, le lapidi, i racconti.
Qui si parlano ancora tre lingue: l’italiano, il croato e lo sloveno. Ma non sempre si capiscono. O non vogliono farlo. A volte sembrano convivere come in un condominio dove gli inquilini si incrociano sulle scale senza mai davvero parlarsi: ciascuno porta ancora addosso la memoria della propria solitudine.
L’Istria è stata romana, veneziana, austriaca, italiana, jugoslava, croata.
E ogni volta ha dovuto cambiare nome alle sue cose: ai paesi, alle vie, alle persone. “Da oggi siete questo”, diceva il potere. Ma la gente non sempre obbediva. E le ferite più recenti non sono antiche abbastanza da essere dimenticate: le foibe (quelle fenditure del Carso dove tra il 1943 e il 1945 vennero gettati, vivi o morti, centinaia di civili italiani), l’esodo, il terrore della pulizia etnica mascherata da razionalizzazione amministrativa.
Nel giro di pochi anni, trecentomila italiani hanno lasciato queste terre. E le loro case sono rimaste lì, con le chiavi nascoste sotto una pietra, come se un giorno qualcuno dovesse tornare.
Ma chi è rimasto? Chi è arrivato dopo? E chi ha imparato a vivere tra il ricordo e il presente?
È qui che comincia il vero racconto.
Pola, la città che ha visto tutto
A Pola la storia più che studiarla, si calpesta. È scritta nella pietra calcarea dell’Arena, nel latino che sopravvive sulle lapidi, ma anche nei cartelli scoloriti che recano ancora un nome slavo sopra uno italiano, oppure il contrario.
Chi arriva distratto vede solo la facciata: un anfiteatro più integro del tempo, piazze ventilate, le cupole austere degli edifici militari della Marina austro-ungarica, che ancora segnano l’orizzonte del porto di Pola. Ma basta spostarsi di qualche metro, entrare in un cortile nascosto o parlare con un anziano seduto all’ombra, perché affiori la vera città: quella che non è mai stata una sola cosa alla volta.
Romani, veneziani, asburgici, italiani, jugoslavi: tutti hanno lasciato un’impronta, ma nessuno ha cancellato la precedente.
Pola fu capitale dell’Istria sotto l’Impero austro-ungarico, divenne italiana nel 1918, e visse il suo periodo più tormentato tra il 1943 e il 1947, tra bombardamenti, esecuzioni sommarie (le cosiddette foibe), e infine l’esodo. Oggi è croata, ma conserva dentro di sé ogni passaggio, come una pelle che non cambia mai del tutto. È questo il segreto scomodo di Pola: essere sempre stata tutto, e per questo non appartenere a nessuno del tutto.
Lì dove un tempo c’era il foro imperiale, oggi si affacciano le memorie dei cantieri navali e dei porti militari. I turisti scattano foto all’anfiteatro, ma pochi notano la modernità fascista che lo incornicia: edifici razionalisti, archi e piazze del Ventennio, pensati per raccontare una nuova italianità – o le cicatrici lasciate dai bombardamenti anglo-americani durante la Seconda guerra mondiale. Quelle cicatrici sono lì, visibili solo a chi guarda oltre il pittoresco: Chi si ferma alla superficie, scatta foto. Chi guarda davvero, sente le voci, crepe nei muri, vuoti nei racconti, giorni che non si commemorano.
Persino le case sembrano portare addosso l’ambiguità di questa terra: facciate asburgiche con infissi italiani, balconi slavi con tende veneziane. Una bellezza dissonante, ma irriducibile.
Eppure Pola non è solo un museo all’aperto. È anche un luogo dove il passato pesa, a volte fino a diventare imbarazzo. Non si sa bene cosa dire, cosa ricordare, quali date celebrare. Per ogni lapide, c’è una storia alternativa. Per ogni nome, un possibile scontro.
E allora si tace, o si cambia discorso. Oppure si ride, come fanno certi istriani anziani, per i quali tutto è già successo troppe volte perché valga ancora la pena arrabbiarsi. Ma sotto quel fatalismo c’è qualcosa di più profondo: la consapevolezza che la storia qui non si dimentica perché non è mai finita.
Una storia rimossa
l’esodo degli italiani d’Istria
La seconda guerra mondiale non finì mai davvero, in Istria. O meglio: finì troppo tardi, e troppo in fretta. Mentre l’Italia firmava l’armistizio, nel settembre del 1943, l’Istria piombava nel caos: abbandonata dai fascisti, occupata dalle truppe partigiane jugoslave, attraversata da rappresaglie e vendette incrociate. In quelle settimane, e poi nei mesi successivi, centinaia di italiani furono infoibati, spesso senza processo, e gettati nelle cavità carsiche, colpevoli o solo sospettati di essere collaborazionisti o semplicemente « nemici del popolo ». Fu il primo trauma di un dopoguerra che in Istria non finì mai davvero – ancora oggi conteso nella memoria.
Va ricordato che, prima del 1947, l’Istria era a pieno titolo territorio italiano.
Prima della guerra, secondo il censimento italiano del 1936, oltre il 60% della popolazione istriana si dichiarava italiana. Dopo il 1947, la percentuale crollò: oggi la comunità italiana rappresenta meno del 5% degli abitanti. Non si tratta solo di numeri, ma di una trasformazione radicale della geografia culturale della regione.
Il Trattato di Parigi ne sancì il passaggio alla Jugoslavia, ma per molti quel confine tracciato sulla carta fu una frattura nella carne viva delle famiglie. Poi venne la pace, almeno ufficialmente. Ma non portò giustizia: portò un nuovo potere, un nuovo confine, e un cambio radicale d’identità.
Con il Trattato di Parigi del 1947, gran parte dell’Istria passò dalla sovranità italiana a quella jugoslava. Nel giro di pochi mesi, la vita quotidiana cambiò volto: le scuole, gli uffici, le insegne, le leggi, tutto passò sotto controllo del nuovo Stato. Per chi si sentiva italiano, o semplicemente non voleva rinunciare a esserlo, la prospettiva era chiara: restare in un Paese che non era più il proprio, o partire. E così cominciò l’esodo. Non fu un’evacuazione organizzata. Fu un esodo lento, doloroso, pieno di paure e di addii non detti.
Tra il 1947 e il 1956, quasi 250.000 italiani (secondo alcune stime oltre 300.000, includendo Fiume e la Dalmazia) lasciarono l’Istria, Fiume e Zara. Alcuni erano italiani di cultura, altri mistilingui, altri ancora slavi italianizzati. Ma tutti avevano in comune una cosa: sentivano di non poter più restare.
Molti finirono nei campi profughi italiani, per anni, senza lavoro e senza più un paese. Altri si dispersero per l’Europa e le Americhe. Alcuni tentarono il ritorno, pochi ci riuscirono.
Non portarono via quasi nulla, ma lasciarono tutto. Nel frattempo, le loro case abitate da altri, i nomi cancellati, le storie sepolte sotto nuove narrazioni.
Nella Jugoslavia di Tito, l’esodo non fu mai raccontato come trauma. Fu visto come un effetto collaterale della costruzione di una nuova patria socialista e multietnica. Solo decenni dopo, e lentamente, anche le società croata e slovena hanno iniziato a fare i conti con quella pagina taciuta. Ma la storia non finisce nei numeri, nei trattati, nelle date scolpite. Perché ci sono anche le storie. Non una soltanto, ma molte. Minute, tenaci, disperse. Che restano attaccate alle mani, alle chiavi, agli sguardi degli ultimi testimoni. Non chiedono di essere spiegate. Solo ascoltate.
La nostalgia degli uni, il silenzio degli altri
Ogni istriano ha una storia, ma non sempre può raccontarla. O non trova chi voglia ascoltarla.
Alcune di queste memorie hanno trovato voce nella letteratura: come nel romanzo di Anna Maria Mori e Nelida Milani, Bora. Istria, il vento dell’esilio, pubblicato nel 1998, che racconta l’esodo dal punto di vista delle donne e dell’intimità perduta, o nei versi aspri e precisi di Giacomo Scotti, poeta e testimone di frontiera. Anche il teatro e la musica hanno raccolto queste voci. Come Magazzino 18, lo spettacolo ideato dal cantautore Simone Cristicchi, che ha avuto il coraggio di dare voce a una memoria scomoda, con rigore et delicatezza, intrecciando canzoni, documenti e testimonianze vere. Una delle rare opere contemporanee capaci di portare sul palco una memoria rimossa senza cedere alla propaganda. Altre memorie sono rimaste ferme dentro un cassetto, accanto a una vecchia chiave arrugginita. Quelle chiavi, a centinaia, le portavano al collo gli esuli italiani quando lasciavano Pola, Rovigno, Dignano, Zara. Non erano simboliche. Erano vere. Aprivano ancora porte, stanze, cortili. Solo che dentro, ormai, non c’era più nessuno ad aspettarli.
Quei trecentomila partiti in silenzio, spesso in fretta, senza sapere con certezza dove stessero andando, portavano con sé una patria che non sapevano più dove fosse. Alcuni scapparono per paura, altri furono espulsi o pressati, altri ancora partirono convinti di tornare. Ma il ritorno, per la maggior parte di loro, non è mai stato possibile.
Chi è rimasto, invece, ha imparato a convivere con l’assenza. Per molto tempo, nei manuali scolastici croati e sloveni, l’esodo fu ridotto a una nota a piè di pagina, quando non del tutto omesso. La difficoltà di raccontare un trauma vissuto dagli “altri” ha spesso avuto la meglio sulla volontà di comprensione. E con una presenza muta: case abitate da altri, nomi cambiati, fotografie sparite. Per molti croati e sloveni nati dopo l’esodo, quella storia è rimasta a lungo evitata. Non per malafede, ma per imbarazzo, per fatica, per una rimozione utile alla costruzione di un’identità nazionale nuova.
Ma la rimozione genera fantasmi. E l’Istria è piena di fantasmi gentili: bambini scomparsi dalle fotografie, nomi italiani scoloriti sulle porte, lapidi abbandonate tra l’erba.
E poi ci sono i ritorni, rari e tremanti, degli eredi degli esuli: tornano d’estate, chiedono dove fosse la casa del nonno, si fermano a guardare un muro, una finestra, un cortile. Non rivendicano, ma nemmeno dimenticano. E spesso trovano davanti a sé uno sguardo incerto, a metà tra la curiosità e la difesa. Perché se è vero che l’esodo è una ferita ancora aperta per molti italiani, lo è anche per chi ha dovuto abitare quel silenzio. In questa terra, ogni storia ha il suo rovescio, e nessuna verità può bastare da sola.
M.C.
TESTIMONIANZE
Tre voci, tre sguardi. L’Istria vista da chi l’ha lasciata, da chi l’ha ritrovata, da chi ci è rimasto.
Le tre storie che seguono sono ispirate a fonti reali: archivi pubblici, interviste, documentari RAI, libri di memorie, atti di convegni. Non sono invenzioni, ma ricostruzioni fedeli di voci ascoltate, lette, tramandate. Verità profonde di un’esperienza storica collettiva.
GIOVANNI
CLASSE 1935
L’ESULE
“Avevo nove anni quando mio padre ci disse che saremmo partiti. Era gennaio, faceva freddo, e la mamma preparò tutto in silenzio. Non capivo molto. Solo che il mio amico Josip non l’avrei più rivisto, e che la nostra casa, quella con l’albero di fico in cortile, non l’avremmo portata con noi. Misi nella valigia un quaderno, una foto, e una chiave. La chiave di casa, naturalmente.
Partimmo su un camion scoperto, poi un treno, poi un altro treno. Ricordo più le facce che i luoghi. Facce che non sapevano se piangere o restare dritte.
A Firenze ci misero in una baracca di legno, con altre famiglie. Mio padre trovò lavoro dopo un anno. Io imparai l’italiano degli italiani. Quello mio, istriano, non si sentiva più.
Oggi quella chiave la tengo in un cassetto. Ogni tanto la guardo. Non ho mai più visto la casa. Dicono che non esiste più. Ma io, in sogno, ci torno sempre”.
ELISA
NIPOTE D’ESULI
L’EREDE
“Sono andata a Rovigno per la prima volta a trent’anni. Sapevo che i miei nonni erano nati lì, che poi erano “scappati”, ma non si parlava mai davvero di quel passato. Ho preso una stanza in centro, vicino al porto. Poi ho cominciato a camminare. Cercavo la via, la casa. Avevo solo un nome scritto su una lettera: “Ulica Grisia”.
Quando l’ho trovata, ho sentito una stretta. Come se qualcosa che non avevo mai conosciuto mi stesse riconoscendo. Non ho suonato. Ho solo guardato. Poi un signore anziano è uscito con una busta della spesa. Mi ha chiesto in croato se cercavo qualcosa. Gli ho risposto in italiano. Mi ha sorriso, poi ha detto: “Qui, prima, c’erano altri nomi”. Non mi ha chiesto chi ero. Né io a lui.
Abbiamo parlato cinque minuti, con poche parole. Quando me ne sono andata, mi ha salutata con la mano. Tornata in Italia, ho detto a mia madre che avevo visto la casa. Lei ha fatto sì con la testa. E non ha detto altro.”
BRANKO
IL FIGLIO DI CHI RESTÒ
IL TESTIMONE
“Sono nato a Pisino nel 1960. Per me l’Istria è sempre stata croata, anche se mio padre parlava
un misto strano di dialetto e italiano. A casa nostra si parlava poco di prima. Dicevano solo: “Qui c’era altra gente”. Quando ero ragazzo, una volta è arrivata una signora dall’Italia. Chiese se poteva entrare. Mia madre era imbarazzata. Poi la fece accomodare.
Quella donna guardava tutto come si guarda un sogno perso. Mi ricordo che toccò il muro del salotto, e disse: “Qui c’era l’armadio di mio padre”. Poi ci ringraziò e se ne andò. Non volle niente. Io quella scena non l’ho mai dimenticata.
Da allora ho capito che la mia terra ha molte storie, non solo la mia. E che certe ferite non si chiudono, ma si attraversano. Forse è proprio questo che insegna l’Istria: che la verità non è mai una sola, e che il compito della memoria non è giudicare, ma accogliere tutte le voci che il tempo aveva zittito. Forse è proprio questo il destino dell’Istria: ogni volta che la racconti, una memoria che credevi perduta si risveglia da qualche parte.”